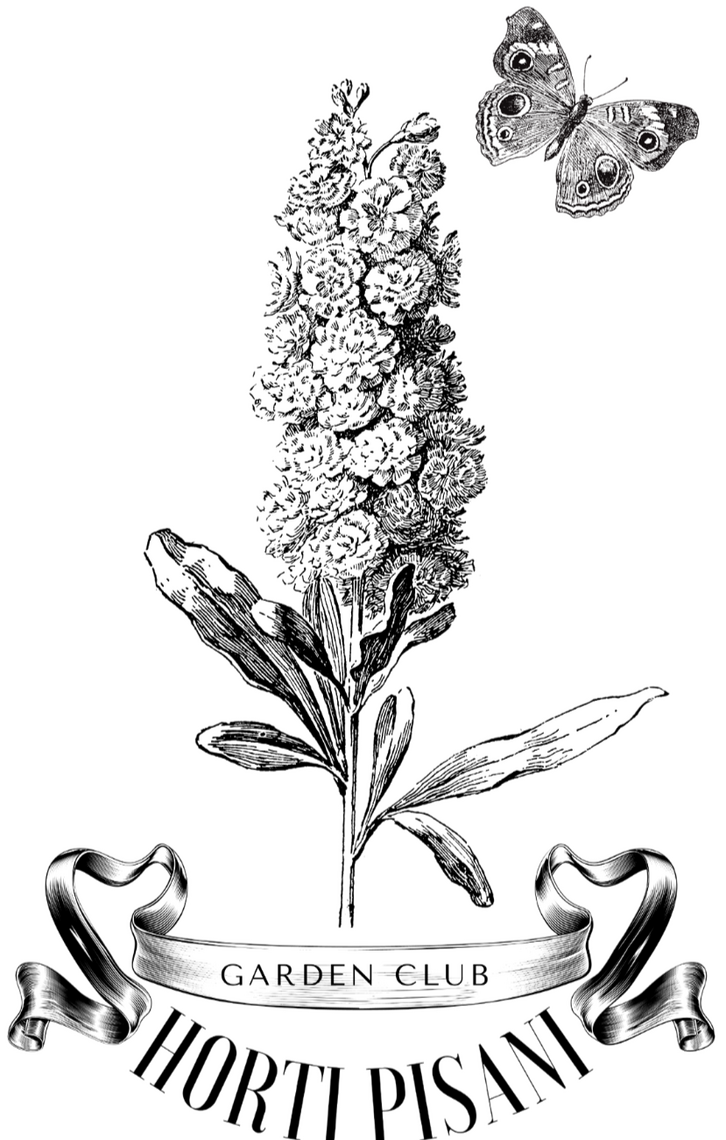L’iperico, il perforatum, che cresce spontaneo nei prati assolati di montagna, non è mai stato una pianta decorativa. Veniva coltivata dai farmacisti nei loro orti, detti “dei semplici”. Cinquecento sono le specie conosciute, e molte sono le varietà usate per i giardini: le più conosciute sono quelle dell’Hypericum inodorum, varietà Magical Kolmbeau, la Universe o la Hidcote. Tutte hanno grandi fiori giallo acceso, a coppa, semplici; iniziano a fiorire da fine luglio, seguitando fino in ottobre. Creano grandi cuscini, allargandosi negli anni. In autunno e in inverno le bacche sono colorate di rosso o di rosa, molto amate dagli uccelli.
Le varietà che ho citato sono semi-sempreverdi, molto rustiche (vuol dire che resistono alle basse temperature e hanno poche pretese), e crescono in ogni terreno, sempre che non sia acido. Sopportano bene la siccità, dopo essersi assestate – ci mettono circa due anni dopo averle piantate. Prima bisogna bagnarle senza esagerare, in modo che le radici si sviluppino bene. Crescono benissimo anche in vaso. Consolidano scarpate, sono di bassa manutenzione, amano il sole , ma prosperano anche in una mezz’ombra luminosa.
Il momento dell’iperico che cresce selvatico, invece, sarebbe la notte di San Giovanni, il 24 giugno. Per chi ha la tendenza all’esoterismo e alle magie, intendo. È stato per anni una pianta ignorata – seguo le “tendenze” da quarant’anni – poi ritornata in voga da quando le moderne fattucchiere l’hanno riscoperto e ne magnificano le proprietà curative. Cito da un articoletto di “Etnobotanica” su facebook: “Durante le crociate sia l’enolito (vino medicato come vulnerario) che l’oleolito (olio di San Giovanni come balsamo) erano largamente ed efficacemente impiegati nella cura di ferite sanguinanti e bruciature…per questo l’iperico è tradizionalmente chiamato scacciadiavoli. …In entrambi i casi la fede ci ha visto il divino; le foglie macchiano le dita di rosso sanguigno…sarebbero stille di sangue di S. Giovanni…” eccetera.
Quello che credevano i crociati forse non è più valido. Che l’iperico sia una pianta particolare, però, non lo vogliamo negare. Guardando le foglie controluce, scopriamo dei piccoli puntini traslucidi. Sono delle ghiandole contenenti una sostanza oleosa; sui margini della foglia vediamo dei puntini neri (è l’ipericina), l’origine della colorazione rossastra delle dita se si sfregano le foglie.
La pianta è usata nelle fitoterapie contro disturbi depressivi, oppure contro ragadi o abrasioni della cute. Però non mi fiderei molto: contro le depressioni serve una cura medica, e l’uso dell’iperico in qualsiasi forma va seguito da un medico che ne ha studiato a fondo le proprietà.
Io maceravo nell’olio di oliva al sole una piccola manciata di fiori e foglie per una settimana – usavo questo macerato a gocce intiepidite su un batuffolo di ovatta per le otiti improvvise dei miei bambini (se però non passava il mal d’orecchie dopo due giorni, telefonavo al pediatra). L’olio d’iperico ha proprietà antibatteriche blande. Una conoscente invece, che ha continuato per mesi a bere la tisana di fiori e di foglie, ha dovuto curarsi per una gravissima intossicazione del fegato.
Irritazioni cutanee sono abbastanza comuni se ci si espone al sole durante una cura con l’iperico in qualsiasi forma.
Euodia daniellii
Proviene dalla Cina e dalla Corea; una pianta mellifera che dicono sia la felicità degli apicoltori. Hanno calcolato che un albero di euodia faccia produrre agli alveari milleduecento kg di miele l’anno. È un albero di medie dimensioni, cresce velocemente una volta messo a dimora. La sua fioritura inizia in piena estate, quando le fonti di polline e nettare sono diventate ormai scarse. La fioritura è molto profumata, ma non da tutti gradita. Per questo in tedesco, oltre a chiamarsi Bienenbaum, albero delle api, viene chiamato anche Stinkesche, frassino maleodorante. Andrebbe piantato ai margini di campi o giardini, o vicino al pollaio per fare ombra ai polli, magari assieme a un Cornus mas, il corniolo, un Salix caprea, accompagnati da una siepe di edera, tutte piante utilissime agli insetti. Cornus e Salix iniziano a fiorire a fine febbraio (questo da noi nelle Alpi; in Toscana probabilmente fioriscono molto prima) e l’edera, che fiorisce in autunno inoltrato. Così si servono api, bombi e affini (che l’umanità ora ha scoperto siano utilissimi, dopo che li ha quasi sterminati con i pesticidi) dalla primavera fino agli inizi dell’inverno.
Ora all’albero hanno cambiato il nome (non esiste Gilda più caciarona e confusionaria dei botanici): lo chiamano Tetradium danielli.
Martha Canestrini